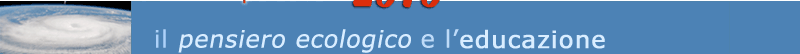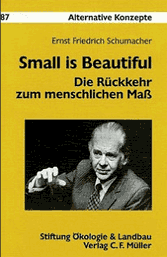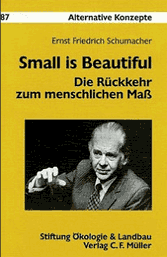
|
|
LA PIU’
GRANDE DELLE RISORSE: L’EDUCAZIONE
di E.F. SCHUMACHER
traduzione di Franca Bossalino
In tutta la storia e virtualmente in ogni parte
della terra gli uomini hanno vissuto moltiplicandosi e creando alcune
forme di cultura. Sempre e dovunque hanno trovato i mezzi di sussistenza
e qualcosa da conservare. Si sono costruite le civiltà, che
si sono prima sviluppate e- in molti casi- sono decadute e si sono
estinte.
Non è questo il luogo per discutere sul perché si
siano estinte; ma possiamo dire che deve essere venuta meno qualche
risorsa; dal momento però che, in molti casi, sulla stessa
terra sono nate nuove civiltà, ciò sarebbe assolutamente
incomprensibile se si fosse trattato semplicemente di risorse materiali.
Come avrebbero potuto tali risorse rigenerarsi?
Tutta la storia, come pure tutta l’esperienza presente, ci
dice che la risorsa principale non è la natura, ma l’uomo
e che l’elemento chiave di tutto lo sviluppo economico nasce
dalla mente dell’uomo. Improvvisamente, c’è un’esplosione
di audacia, di iniziativa, di invenzione, di attività costruttiva,
non in uno solo ma- simultaneamente- in molti campi. Nessuno può
dire da dove scaturisca, ma possiamo vedere come permane e come
si rafforza attraverso una varietà di scuole; in altre parole,
attraverso l’educazione. Perciò, molto concretamente,
possiamo dire che l’educazione é la più vitale
delle risorse.
Se la società occidentale è in uno stato di crisi
permanente non è inverosimile suggerire che qualcosa non
va nella sua educazione. Nessuna civiltà, sono sicuro, ha
mai dedicato più energie e risorse all’educazione organizzata
e, se non crediamo in niente altro, certamente crediamo che l’educazione
è - o dovrebbe essere- la chiave per qualunque cosa... ...Se
l’era nucleare e’ portatrice di nuovi pericoli; se il
progresso dell’ingegneria genetica apre le porte a nuovi abusi;
se il commercialismo fornisce nuove tentazioni- la risposta deve
essere una maggiore e migliore educazione. Il modo di vivere moderno
sta diventando sempre più complesso: ciò significa
che tutti debbono avere un’educazione più elevata.
Recentemente si è detto : <...
si auspica che nel 1984 il più comune degli uomini non avrà
alcun imbarazzo nell’usare la tavola dei logaritmi, i concetti
elementari del calcolo e nel definire ed usare parole come elettrone,
coulomb, e volt. E che, inoltre, sarà diventato capace non
solo di maneggiare una penna, una matita e un righello ma anche
un nastro magnetico, una valvola e un transistor. Il progresso della
comunicazione tra gli uomini dipende da questo>
Sembra, soprattutto, che la situazione internazionale richieda dei
prodigiosi sforzi educativi. Una dichiarazione importante su questo
punto fu rilasciata qualche anno fa da Sir Charles Snow (ora divenuto
Lord) nella sua Conferenza di Rede: <Dire
che dobbiamo educarci o perire e’ un po’ più
melodrammatico di quanto i fatti giustifichino. Dire che dobbiamo
educarci o nel corso della nostra vita assisteremo a un rapido declino
e’ quasi giusto.>
Secondo Lord Snow, i Russi apparentemente stanno facendo meglio
di qualunque altro popolo e “avranno un netto vantaggio “a
meno che- e fino a che- gli americani e noi stessi non educheremo
la nostra sensibilità e la nostra immaginazione.
Si ricorderà che Lord Snow parlò delle “Due
Culture e la Rivoluzione Scientifica” esprimendo la sua preoccupazione:
<... la vita intellettuale dell’intera
società occidentale si sta separando sempre più in
due polarità......Da una parte abbiamo gli intellettuali
letterati...dall’altra gli scienziati.> La scienza
e l’ingegneria producono know-how; ma il know-how in sé
non è niente.
E’ un mezzo senza un fine, una pura potenzialità, una
frase non finita. Il know-how è cultura quanto un pianoforte
è musica. Può l’educazione aiutarci a finire
la frase, a trasformare la potenzialità in realtà,
a beneficio dell’uomo?
Per fare ciò il compito dell’educazione sarebbe, innanzi
tutto e sopratutto, la trasmissione di idee di valore, idee su che
cosa fare con le nostre vite. Non c’e alcun dubbio sulla necessità
di trasmettere know-how ma questo deve essere al secondo posto,
perchè è, ovviamente, alquanto azzardato mettere un
grande potere nelle mani delle persone senza avere la certezza che
queste abbiano un’ idea ragionevole sul come e a quale scopo
usarlo. Attualmente non si può metter in dubbio che l’intera
umanità sia in pericolo, non perchè ci manchi il know-how
scientifico e tecnologico, ma perchè tendiamo a usarlo per
distruggere, senza saggezza.
Più educazione può aiutarci soltanto se produce più
saggezza. L’essenza dell’educazione, a mio parere, è
la trasmissione dei valori, ma i valori non ci aiutano a scegliere
la strada nel corso della vita, a meno che non siano diventati nostri:
una parte, come si dice, del nostro make-up. Ciò significa
che i valori sono più che semplici formule o asserzioni dogmatiche:
che noi pensiamo e sentiamo con quelli, che sono proprio gli strumenti
attraverso i quali noi guardiamo, interpretiamo il mondo e ne facciamo
esperienza. Quando noi pensiamo, non pensiamo soltanto: pensiamo
con le idee. La nostra mente non e’ una vuota tabula rasa.
Quando cominciamo a pensare possiamo farlo solo perchè la
nostra mente è già piena di ogni genere di idee con
cui pensare.
Durante la gioventù e l’adolescenza, prima che la mente
cosciente e critica cominci ad agire come una specie di censore
e guardiano della soglia, una moltitudine di idee si infiltra nella
nostra mente. Questi anni si potrebbe dire che sono gli anni bui
durante i quali riceviamo semplicemente un’eredità;
è solo negli anni successivi che gradualmente impariamo a
selezionare la nostra eredità. Innanzitutto c’e’
il linguaggio. Ogni parola e’ un’idea. Se il linguaggio
che penetra dentro di noi durante gli anni bui è l’inglese,
la nostra mente viene attrezzata da un insieme di idee che è
notevolmente differente da quello rappresentato dal cinese, dal
russo, dal tedesco o perfino dall’americano. Accanto alle
parole ci sono le regole del metterle insieme: la grammatica, un
altro pacchetto di idee il cui studio ha affascinato alcuni filosofi
moderni a tal punto che hanno pensato di poter ridurre l’intera
filosofia allo studio della grammatica.
Tutti i filosofi- e non solo - hanno sempre posto moltissima attenzione
alle idee viste come il risultato del pensiero e dell’osservazione;
nei tempi moderni invece troppo poca attenzione si è data
allo studio delle idee che costituiscono proprio quegli strumenti
per mezzo dei quali pensiero e osservazione procedono. Sulla base
dell’esperienza e del pensiero consapevole le piccole idee
possono venire rimosse, ma quando si tratta di idee più grandi,
universali, o più sottili, può non essere tanto facile
cambiarle. Infatti, è spesso difficile prenderne coscienza,
dal momento che sono strumenti e non il risultato del nostro pensiero-
allo stesso modo in cui riusciamo a vedere quello che e’ fuori
di noi ma non riusciamo facilmente a vedere quello con cui vediamo,
cioè l’occhio stesso.
E anche quando se ne fosse presa coscienza è spesso impossibile
giudicarle sulla base dell’esperienza comune. Spesso notiamo
l’esistenza di idee più o meno fisse nella mente degli
altri- idee con cui pensano senza rendersi conto di farlo.
Le chiamiamo pregiudizi, che è logicamente corretto perchè sono
semplicemente entrate nella mente e non sono in alcun modo il risultato
di un giudizio. Ma la parola pregiudizio è in generale applicata
a idee che sono palesemente erronee e riconoscibili come tali da
chiunque, tranne che da chi le ha. Molte delle idee con cui pensiamo
non sono affatto di quel genere. Ad alcune di esse non possono nemmeno
applicarsi le nozioni di verità o di errore, come quelle
incorporate nelle parole e nella grammatica; altre non sono propriamente
pregiudizi, ma il risultato di un giudizio; altre ancora sono tacite
assunzioni o presupposizioni che può essere molto difficile
riconoscere.
Perciò dico che noi pensiamo con o attraverso idee e che
quello che più in generale chiamiamo il pensare è
l’applicazione di idee che pre-esistono a una determinata
situazione o a un insieme di fatti. Quando pensiamo, per esempio,
alla situazione politica, applichiamo a quella situazione le nostre
idee politiche, più o meno sistematicamente e tentiamo di
rendere quella situazione intelleggibile a noi stessi attraverso
quelle idee. Similmente in qualunque altro caso. Alcune idee sono
idee di valore, cioè a dire, noi valutiamo la situazione
alla luce delle nostre idee-valori.
Il modo in cui facciamo esperienza e interpretiamo il mondo, ovviamente,
dipende molto dal genere di idee che ci riempiono la mente. Se sono
prevalentemente modeste, deboli, superficiali e incoerenti, la vita
apparirà insipida, non interessante, banale e caotica. E’
difficile sopportare il sentimento di vuoto che ne deriva e il vuoto
della nostra mente può soltanto essere riempito da qualche
grande e fantastico concetto- politico o altro- che improvvisamente
sembra illuminare ogni cosa e dare significato e scopo alla nostra
esistenza. Non c’è bisogno di sottolineare che proprio
in ciò sta il grande pericolo del nostro tempo.
Quando si chiede ‘educazione’, si intende qualcosa di
più che la semplice istruzione, qualcosa di più che
la semplice conoscenza dei fatti. Forse non si sa nemmeno che cosa
si sta cercando; io credo che quello che si cerca davvero sono idee
che rendano il mondo e la vita di ciascuno più comprensibili
a noi stessi. Quando una cosa è comprensibile si sente di
partecipare; quando una cosa non lo è ci si sente estranei.
Se la mente non può affrontare il mondo con una serie- o,
dovremmo dire, con una attrezzatura di idee potenti, il mondo deve
apparirle un caos, una massa di fenomeni scollegati, di eventi privi
di senso. In questo caso l’ uomo è una persona in una
terra straniera priva di qualunque segno di civilizzazione, senza
mappe o cartelli stradali o indicazioni di alcun genere. Niente
ha significato per lui, niente può catturare il suo interesse
vitale; non ha alcun mezzo per rendere alcunché comprensibile
a se stesso. Tutta la filosofia tradizionale è un tentativo
di creare un sistema ordinato di idee per mezzo delle quali vivere
e interpretare il mondo. L’estraneamento alimenta la solitudine
e la disperazione, l’incontro con il niente, il cinismo, i
vuoti gesti di sconfitta, come possiamo vedere nella maggior parte
della filosofia esistenzialista e nella letteratura oggi.
Allora, qual’è la causa dell’estraneamento? La
scienza non è mai stata più trionfante, il potere
dell’uomo sul suo ambiente non è mai stato più
completo né il suo progresso più veloce. Non può
essere una mancanza di know-how la causa della disperazione, non
solo di pensatori religiosi come Kirkegaard, ma anche di illustri
matematici e scienziati come Russell e Hoyle.
Noi sappiamo fare molte cose, ma sappiamo che cosa fare?
Ortega y Casset pone la questione in modo succinto: <Non
possiamo vivere al livello umano, senza idee. Da queste dipende
quello che facciamo. Vivere è, né più e né
meno che il fare una cosa invece di un’altra>. Che
cos’è allora l’educazione? E’ la trasmissione
di idee che mettono in grado l’uomo di scegliere una cosa
o un’altra, o, per citare ancora Ortega, <di vivere una vita che sia qualcosa al di sopra della tragedia senza
senso o del castigo interiore>
Come potrebbe, ad esempio, una conoscenza della Seconda Legge della
Termodinamica aiutarci in questo? Lord Snow ci dice che alle persone
colte che deplorano l’analfabetismo degli scienziati a volte
domanda: <Quanti di voi potrebbero descrivere la Seconda Legge
della Termodinamica?> La risposta, dice, è, in genere,
fredda e negativa. <Eppure>
seguita <ho chiesto qualcosa che riguarda
l’equivalente scientifico di ‘Avete letto un’opera
di Shakespeare?’> Tale affermazione sfida le fondamenta
della nostra civiltà. Quello che conta è l’attrezzatura
di idee con le quali, per mezzo delle quali, attraverso le quali,
facciamo esperienza del mondo e lo interpretiamo. La Seconda legge
della Termodinamica non è niente più che un’ipotesi
operativa adatta a vari generi di ricerca scientifica. Dall’altra
parte c’è un’opera di Shakespeare: traboccante
delle idee più vitali sullo sviluppo interiore dell’uomo,
mostra la grandezza e la miseria dell’esistenza umana. Come
potrebbero queste due cose essere equivalenti?
Che cosa manca a me, in quanto essere umano, se non ho mai sentito
parlare della seconda legge della Termodinamica? La risposta è:
niente. E che cosa perdo se non conosco Shakespeare? A meno che
io non derivi la mia capacità di comprendere da un’altra
fonte, la risposta è: perdo semplicemente la mia vita. Dovremmo
raccontare ai nostri bambini che una vale l’altra- un po’
di conoscenza della fisica qui e li un po’ di conoscenza di
letteratura?
Se faremo così le colpe dei padri ricadranno sui figli fino
alla terza e alla quarta generazione, poiché questo è
il tempo che ci vuole- di solito- dalla nascita di un’idea
alla sua piena maturità, quando riempie le menti di una nuova
generazione e fa si che quelle pensino per mezzo di essa. La scienza
non può produrre idee per mezzo delle quali possiamo vivere.
Perfino le grandi idee della scienza non sono che ipotesi operative,
utili agli scopi di ricerche speciali, ma completamente inapplicabili
per condurre la nostra vita o per interpretare il mondo.
Pertanto, se un uomo cerca l’educazione perchè si sente
estraniato e stupito, perchè la sua vita gli sembra vuota
e insignificante, non può trovare quello che cerca studiando
le scienze naturali, o acquisendo know-how . Questo studio ha il
suo proprio valore che non sono incline a sminuire, ci dice come
le cose funzionano in natura o nell’ingegneria, ma non ci
dice niente sul significato della vita e non può in alcun
modo curare lo estraneamento e la segreta disperazione.
Dove, allora, dovrà rivolgersi? Forse, a dispetto di tutto
ciò che sentiamo dire sulla rivoluzione scientifica e sul
fatto che la nostra è l’età della scienza, si
rivolgerà alle cosiddette discipline umanistiche. Qui, infatti,
possiamo trovare, se siamo fortunati, idee grandi e vitali con cui
riempire la nostra mente, idee con le quali pensare e attraverso
le quali costruire il mondo e la società e rendere la nostra
stessa vita intelleggibile. Vediamo quali sono le principali idee
che probabilmente troveremmo oggi. Non proverò a farne una
lista completa; mi limiterò ad enumerare sei idee guida,
tutte germogliate nel XIX secolo e che ancora oggi dominano, per
quello che posso vedere, le menti delle persone educate.
1. C’è un’idea
di evoluzione per cui le forme superiori si sviluppano continuamente
dalle forme inferiori secondo una specie di processo naturale e
automatico. Gli ultimi cento anni hanno visto la sistematica applicazione
di questa idea a tutti gli aspetti della realtà senza eccezioni.
2. C’è l’idea della competizione,
della selezione naturale e della sopravvivenza delle specie più
adattabili, il che significa spiegare il processo naturale e automatico
dell’evoluzione e dello sviluppo.
3. C’è l’idea che tutte le più
alte manifestazioni della vita umana, come la religione, la filosofia,
l’arte etc.- quelle che Marx chiama le fantasmagorie del cervello
umano- non siano altro che necessari integratori del processo materiale
della vita, una sovrastruttura eretta per mascherare e promuovere
gli interessi economici, poiché l’intera storia umana
è la storia delle lotte di classe.
4. In competizione- si potrebbe pensare- con l’interpretazione
marxista delle manifestazioni più alte della vita umana,
c’è l’interpretazione freudiana che le riduce
agli oscuri rimescolamenti del subconscio e le spiega semplicemente
come il risultato dei desideri incestuosi non realizzati durante
la fanciullezza e la prima adolescenza.
5. C’è l’idea generale del relativismo,
che nega tutti gli assoluti, dissolve tutte le norme e gli standard
, porta a minacciare profondamente l’idea di verità
nel pragmatismo e influisce anche sulla matematica che è
stata definita da Bertrand Russel come <l’argomento nei
confronti del quale non sappiamo mai di che cosa stiamo parlando
o se quello che diciamo è vero>
6. Infine c’e’ l’idea trionfante
del positivismo, quella valida conoscenza che si può ottenere
solo attraverso il metodo delle scienze naturali e per cui nessuna
conoscenza è genuina a meno che non si basi su fatti generalmente
osservabili. Il positivismo, in altre parole è interessato
unicamente al know-how e nega la possibilità della conoscenza
oggettiva dei significati e delle intenzioni di qualunque genere
essi siano.
Nessuno, credo, sarà disposto a negare la
portata e il potere di queste sei grandi idee. Queste non sono il
risultato di un angusto empirismo. Nessuna di esse potrebbe essere
stata verificata dalle ripetute indagini dei fatti. Queste idee
rappresentano dei formidabili balzi dell’immaginazione nell’ignoto
e nel non conoscibile. Naturalmente il balzo e’ fatto da una
piccola piattaforma di fatti osservabili.
Queste idee non avrebbero potuto alloggiare tanto stabilmente nelle
menti degli uomini, se non avessero contenuto importanti elementi
di verità . Ma la loro caratteristica essenziale è
la pretesa di universalità. L’evoluzione trascina ogni
cosa lungo il suo cammino, non solo i fenomeni materiali, dalle
nebulose all’homo sapiens, ma anche i fenomeni mentali, come
la religione e il linguaggio. Competizione, selezione naturale,
e la sopravvivenza del più adattabile, non sono presentate
come una serie di osservazioni tra le altre ma come leggi universali.
Marx non dice che alcune parti della storia sono storia delle lotte
di classe; no, il materialismo scientifico, non molto scientificamente,
estende questa parziale osservazione a nient’altro che alla
<totalità della storia delle società fin qui esistite>
E, ancora, Freud non si accontenta di riportare un certo numero
di osservazioni cliniche ma fornisce una teoria universale della
motivazione umana, asserendo, per esempio, che tutta la religione
non e’ altro che una neurosi ossessiva. Relativismo e positivismo,
naturalmente, sono dottrine puramente metafisiche, con una distinzione
peculiare e ironica che è quella di negare la validità
di tutta la metafisica, se stesse comprese.
Che cosa hanno in comune le sei grandi idee, oltre alla loro natura
non empirica ma metafisica?Tutte affermano che ciò che prima
era stato considerato come qualcosa di ordine superiore è
in realtà niente altro che una manifestazione più
sottile dell’inferiore- a meno che, in verità, proprio
la distinzione tra superiore e inferiore non venga negata. Perciò
l’uomo, come il resto dell’universo, non è veramente
altro che una disposizione accidentale di atomi.
La differenza tra l’uomo e la pietra è poco più
che un’apparenza ingannevole. Le più alte affermazioni
culturali dell’uomo non sono altro che ingordigia economica
mascherata o il defluire delle frustrazioni sessuali. In ogni caso,
è inutile dire che l’uomo dovrebbe tendere al superiore
piuttosto che all’inferiore, perchè nessun significato
intellegibile può essere riferito a nozioni puramente soggettive
quali quelle di superiore e inferiore, mentre la parola ‘dovrebbe’
è segno di megalomania autoritaria.
Le idee dei padri del XIX secolo sono ricadute sulla terza e quarta
generazione che sono vissute nella seconda metà del XX secolo.
Per i padri, queste idee erano il risultato dei loro processi intellettuali.
Nella terza e quarta generazione, sono diventate strumenti attraverso
i quali si è percepito ed interpretato il mondo. Coloro che
producono le idee raramente sono governati da esse. Ma le loro idee
acquistano potere sulle vite umane nella terza e quarta generazione,
quando sono divenute parte di una grande quantità di idee,
compreso il linguaggio, che vengono assorbite dalla mente dell’individuo
durante i suoi anni bui
Queste idee del XIX secolo alloggiano stabilmente nella mente di
quasi tutti gli occidentali, ancora oggi, siano o no educati. Nelle
menti non educate sono ancora piuttosto farraginose e nebulose,
troppo deboli per rendere intellegibile il mondo. Da qui nasce il
desiderio di educazione, per cosi dire, di qualcosa che ci conduca
fuori dalla foresta oscura della nostra farraginosa ignoranza verso
la luce della comprensione. Ho detto che un’educazione puramente
scientifica non ci può aiutare in questo perchè ha
a che fare soltanto con idee di know-how, mentre noi abbiamo bisogno
di capire perchè le cose sono come sono e che cosa dobbiamo
fare con le nostre vite. Quello che impariamo, studiando una particolare
scienza, è, in ogni caso, troppo specifico e specialistico
per i nostri scopi più ampi. Perciò ci rivolgiamo
alle discipline umanistiche per avere una visione chiara delle grandi
e vitali idee della nostra epoca. E perfino nelle discipline umanistiche
potremmo restare impantanati in una massa di erudizioni specialistiche
che ci riempiono la mente di una quantità di piccole idee
altrettanto inappropriate come quelle che potremmo trovare nelle
scienze naturali.
Ma potremmo anche essere più fortunati (se di fortuna si
tratta) e trovare un maestro che ci “illuminerà la
mente” e renderà chiare le idee- quelle grandi e universali
idee che già esistono– e in tal modo ci renderà
il mondo intelligibile.
Un tale processo meriterebbe davvero di essere chiamato “educazione”.
E che cosa otterremmo oggi? Una visione del mondo come una terra
desolata in cui non c’è né significato né
scopo, in cui la consapevolezza umana è uno sfortunato accidente
cosmico, in cui angoscia e disperazione sono le uniche ultime realtà.
Se attraverso una vera educazione l’uomo riuscisse a scalare
quelle che Ortega chiama ”le cime dei nostri tempi”
si troverebbe in un nulla abissale. Potrebbe udire l’eco di
Byron:
<Dolore è conoscenza; coloro che
più sanno
Più intensamente debbono piangere sulla fatale verità
L’Albero della Conoscenza non e’ quello della Vita>.
In altre parole, perfino una educazione umanistica,elevandoci all’altezza
delle idee dei nostri tempi, non porterebbe niente di buono, perchè
quello che gli uomini sono assolutamente legittimati a chiedere
è una vita più ricca e non il dolore.
Che cosa e’ successo? Come e’stato possibile ?
Le idee guida del XIX secolo che pretendevano di abbandonare la
metafisica, erano esse stesse un genere di metafisica cattivo, pericoloso
e distruttivo.
Noi ne stiamo ancora soffrendo come di una malattia mortale.
Non e’ vero che la conoscenza e’ dolore. Ma errori velenosi
portano dolore illimitato nella terza e nella quarta generazione.
Gli errori non sono nella scienza ma nella filosofia proposta in
nome della scienza Come Etienne Gilson sostenne più di vent’anni
fa:
<Un simile sviluppo non era in alcun modo inevitabile, ma la
progressiva crescita della scienza lo rese sempre più probabile.
L’interesse crescente degli uomini per i risultati pratici
della scienza era in sé naturale e legittimo, ma li ha aiutati
a dimenticare che la scienza è conoscenza e i risultati pratici
niente altro che i suoi risultati....Prima del loro inaspettato
successo nel trovare le spiegazioni conclusive del mondo materiale,
gli uomini hanno cominciato a disprezzare tutte le discipline in
cui tali dimostrazioni non potevano essere trovate, o a ricostruire
quelle discipline secondo i modelli delle scienze fisiche. Di conseguenza,
la metafisica e l’etica dovevano essere o ignorate o, almeno,
sostituite dalle nuove scienze positive; in tutti e due i casi,
sarebbero state eliminate. Una mossa veramente rischiosa, che e’
responsabile della posizione pericolosa in cui la cultura occidentale
si trova adesso.”
Non e’ nemmeno vero che la metafisica e l’etica sarebbero
state eliminate. Al contrario, tutto quello che abbiamo ottenuto
è una cattiva metafisica e un’etica che sgomenta.Egli
deplorava “l’abisso di incomprensione reciproca”
tra i due gruppi e voleva che fosse colmato. E’ perfettamente
chiaro come pensava che questa operazione dovesse essere fatta;
l’obiettivo della sua politica educativa avrebbe, innanzi
tutto, formato <quanti più scienziati
possibile>; avrebbe <addestrato strati più ampi di
professionisti> a fare ricerca di base, design di alto
livello e sviluppo; terzo, avrebbe preparato <migliaia
e migliaia di altri scienziati ed ingegneri>; infine, avrebbe
educato <politici, amministratori, un’intera comunità
a una conoscenza della scienza sufficiente per avere un senso di
quello di cui gli scienziati parlano>
Se questo quarto ed ultimo gruppo può essere educato almeno
ad “avere il senso” di ciò di cui la gente comune,
gli scienziati e gli ingegneri parlano - così sembra suggerire
Lord Snow- l’abisso di reciproca incomprensione tra Le Due
Culture può essere colmato.
Queste idee sull’ educazione che rappresentano molto bene
il nostro tempo, ci lasciano con la sgradevole sensazione che l’uomo
comune, i politici, gli amministratori e così via- non siano
di molta utilità; che non abbiano raggiunto la meta: ma,
almeno, dovrebbero avere un senso di quello che sta succedendo e
sapere che cosa vogliono dire gli scienziati quando parlano- per
citare l’esempio di Lord Snow- della Seconda legge della Termodinamica.
E’ una sensazione sgradevole, perchè gli scienziati
non si stancano mai di dirci che i frutti del loro lavoro sono ”neutrali”:
che arricchiscano l’umanità o la distruggano, dipende
dall’uso che se ne fa. Chi è che decide come usarli?
Non c’è niente nella formazione di scienziati e ingegneri
che li metta in grado di prendere una tale decisione, altrimenti,
che ne è della neutralità della scienza?
Se tanta importanza viene oggi data al potere dell’educazione
al fine di rendere capace la gente comune di affrontare i problemi
creati dal progresso scientifico e tecnologico, ci deve essere allora
qualcosa di più nell’educazione di quanto suggerisce
Lord Snow.
Sentiamo la gente dire: “ma, non lo so”, una protesta
impotente contro la non intelleggibilità del mondo così
come lo incontriamo. <La filosofia, come
i Greci la concepivano> scrive il prof.Kuhn <È
uno sforzo della mente umana di interpretare un sistema di segni
e in tal modo relazionare l’uomo al mondo come ordine comprensibile
al cui interno gli è assegnato un posto.> La cultura
classica cristiana del tardo Medio Evo aveva fornito all’uomo
una interpretazione dei segni completa e sorprendentemente coerente,
un sistema di idee vitali che davano un’immagine dettagliata
dell’uomo, dell’universo, e del posto dell’uomo
nell’universo.
Questo sistema, comunque, è stato demolito e ridotto in frantumi
e il risultato è stato lo stupore e l’estraneamento,
mai posto in modo più drammatico di come ha fatto Kirkegaard
nella metà dell’ultimo secolo: <Uno
infila un dito nel terreno per riconoscere dall’odore in quale
terra si trova: infilo un dito nell’esistenza- non odora di
niente. Dove sono? Chi sono? Da dove vengo? Che cosa è questa
cosa chiamata mondo? Che cosa significa questo mondo? Chi è
che mi ha catturato in questa cosa ed ora mi lascia li?....Come
sono venuto al mondo? Perchè non sono nemmeno stato consultato.....ma
sono stato spinto invece nei ranghi come se fossi stato comprato
da un rapitore di bambini, un venditore di anime? Come ho trovato
interesse in questa grande rappresentazione che chiamano realtà?
Perchè dovrei avere interesse per essa? Non si tratta di
un fatto volontario? E se sono obbligato a parteciparvi, dov’è
il regista? .....Dove dovrei rivolgermi per esprimere le mie lamentele?>
Forse non c’e’ nemmeno un regista. Bertrand Russel disse
che l’universo intero e’ semplicemente <il
risultato di una disposizione accidentale di atomi> e
affermò che le teorie scientifiche che portano a questa conclusione
<se non completamente fuori discussione,
sono quasi tanto certe che nessuna filosofia che le rigetti può
sperare di sopravvivere...Soltanto sulle solide fondamenta di una
disperazione insopportabile l’abitazione dell’anima
può da qui in avanti- essere costruita in modo sicuro.>
Sir Fred Hoyle, l’astronomo, parla della <situazione
davvero terrificante in cui ci troviamo. Eccoci qui in questo fantastico
universo con appena un’indizio della possibilità che
la nostra esistenza abbia alcun significato reale.>
Oppure, improvvisamente, tutto ciò si trasforma- come ho
già ricordato- nell’adozione fervente di insegnamenti
fanatici che, attraverso una mostruosa semplificazione della realtà,
fingono di rispondere a tutte le domande. Gli storici sanno che
gli errori della metafisica possono portare alla morte. R.G.Coleridge
scrisse: <La diagnosi - fatta dai Padri
della Chiesa- della decadenza della civiltà greco-romana,
attribuisce quell’ evento a una malattia metafisica....Non
fu l’invasione dei barbari a distruggere il mondo greco-romano.....La
causa fu una causa metafisica. Il mondo pagano stava fallendo nel
tenere in vita le proprie fondamentali convinzioni, [scrissero i
Padri] perchè a causa degli errori fatti dall’analisi
metafisica, era diventato confuso proprio dire quali fossero queste
convinzioni...Se la metafisica fosse stata semplicemente un lusso
intellettuale, ciò non avrebbe avuto importanza>.
Questo passaggio può essere applicato, senza alcun cambiamento-
alla civiltà odierna Noi siamo confusi rispetto a quali siano
davvero le nostre convinzioni.
Le grandi idee del XIX secolo possono riempirci la mente in un modo
o nell’altro, ma i nostri cuori non ci credono comunque.
Sono la mente e il cuore ad essere in guerra tra loro, non la ragione
e la fede, come comunemente si afferma. La nostra ragione è
oscurata da una fede straordinaria, cieca e irragionevole in una
serie di fantastiche idee che distruggono la vita ereditate dal
XIX secolo. Il principale compito della nostra ragione è
il recupero di una fede più vera di quella.
L’educazione non può aiutarci finché non restituisce
spazio alla metafisica. Che le materie insegnate siano quelle della
scienza o delle discipline umanistiche, se l’insegnamento
non porta a una chiarificazione della metafisica, cioè a
dire, delle nostre fondamentali convinzioni, non può educare
un uomo e conseguentemente, non può avere alcun valore reale
per la società.
Spesso si afferma che l’educazione sta crollando a causa della
iper- specializzazione. Ma questa è solo una diagnosi parziale
e fuorviante.
La specializzazione non è in sé un principio educativo
sbagliato.
Quale sarebbe l’alternativa: una superficiale conoscenza amatoriale
di tutte le principali discipline? O un lungo studium generale in
cui si è obbligati a perdere tempo annusando discipline che
non si desidera conoscere, mentre si e’ tenuti lontani da
ciò che veramente si vuole imparare? Questa non può
essere la risposta giusta dal momento che può portare soltanto
al tipo di uomo intellettuale che il Cardinal Newman condannava-
<…. un intellettuale, come il mondo
di oggi lo concepisce....uno pieno di ‘punti di vista’
su tutti gli argomenti della filosofia, su tutti i fatti del giorno.>
Questo è un segno di ignoranza piuttosto che di conoscenza.
<Debbo insegnarvi il significato di conoscenza?>
disse Confucio.
<Quando sai una cosa, riconoscere di
saperla, e quando non la sai, sapere di non saperla: questa è
la conoscenza>
La colpa non è della specializzazione ma della mancanza di
profondità con cui le discipline vengono di solito presentate
e l’assenza di consapevolezza metafisica.
Le scienze vengono insegnate senza alcuna consapevolezza dei presupposti
della scienza, del significato e delle implicazioni delle leggi
scientifiche e del posto occupato dalle scienze naturali all’interno
della totalità del cosmo del pensiero umano. Il risultato
è che i presupposti della scienza vengono normalmente confusi
con le sue scoperte.
L’economia viene insegnata senza alcuna consapevolezza della
visione della natura umana che è alla base della teoria economica
del nostro tempo.
Molti economisti infatti sono essi stessi inconsapevoli del fatto
che tale visione è implicita nei loro insegnamenti e che
quasi tutte le loro teorie cambierebbero se quella visione cambiasse.
Come potrebbe esserci un insegnamento razionale della politica senza
riportare tutte le questioni alle loro origini metafisiche?
Il pensiero politico non può che essere necessariamente confuso
e alla fine incomprensibile se c’è un continuo rifiuto
ad ammettere lo studio serio dei problemi metafisici ed etici che
vi sono implicati. La confusione è già tanto grande
che è legittimo dubitare del valore educativo dello studio
di molte delle cosiddette discipline umanistiche.
Dico “così dette” perchè una disciplina
che non rende esplicita la sua visione della natura umana può
difficilmente essere chiamata umanistica.
Tutte le discipline, non importa quanto specialistiche, sono connesse
con un centro; sono come i raggi che emanano dal sole. Il centro
è costituito dalle nostre basilari convinzioni, da quelle
idee che davvero hanno il potere di muoverci. In altre parole il
centro consiste di metafisica ed etica, di idee che- ci piaccia
o no- trascendono il mondo dei fatti.
Poichè trascendono il mondo dei fatti, non possono essere
approvate o disapprovate dal metodo scientifico comune. Ma ciò
non significa che siano puramente “soggettive” o “relative’
o semplicemente convenzioni arbitrarie. Debbono essere fedeli alla
realtà, sebbene trascendano il mondo dei fatti: un apparente
paradosso per i nostri pensatori positivisti. Se non sono fedeli
alla realtà, aderire a tale insieme di idee inevitabilmente
porta al disastro.
L’educazione ci aiuta se produce “uomini interi”.
L’uomo veramente educato non è un uomo che conosce
un pò di ogni cosa, né un uomo che conosce i dettagli
di ogni disciplina (ammesso che sia possibile): “l’uomo
intero” infatti può avere poca conoscenza dettagliata
dei fatti e delle teorie, può tenere l’Enciclopedia
Britannica perchè “lei sa e a lui non serve”,
ma sarà veramente a contatto con il centro.
Non avrà dubbi sulle sue convinzioni, sulla sua visione del
significato e dello scopo della sua vita. Può non essere
capace di spiegare queste cose con le parole, ma la condotta della
sua vita mostrerà una certa sicurezza del tocco che deriva
dalla sua chiarezza interiore. Cercherò di spiegare un po’
meglio che cosa si intende per ‘centro’.
Tutta la attività umana insegue qualcosa che si pensa sia
buono. Questa non e’ niente di più che una tautologia,
ma ci aiuta a porre la domanda giusta: ”Buono per chi?”
“Buono per la persona che lo sta inseguendo”. Perciò
a meno che quella persona non abbia ordinato e coordinato i suoi
molteplici bisogni, impulsi e desideri, i suoi sforzi sono probabilmente
confusi, contraddittori, frustranti e probabilmente auto distruttivi.
Il “centro” ovviamente,è il luogo in cui l’uomo
deve creare per se stesso un sistema ordinato di idee su se stesso
e sul mondo, che regolino la direzione dei suoi vari sforzi.
Se non ci ha mai pensato (perchè è sempre troppo impegnato
con cose più importanti, o perchè è orgoglioso
di pensare “ umilmente”a se stesso come un agnostico),
il centro non sarà comunque vuoto: sarà pieno di tutte
quelle idee vitali che, in un modo o nell’altro, sono filtrate
nella sua mente durante gli anni bui.
Ho cercato di descrivere quali sono, oggi, quelle idee: una totale
negazione del significato e dello scopo dell’esistenza umana
sulla terra che porta alla disperazione totale di chiunque creda
in esse. Fortunatamente, come ho detto, il cuore spesso è
più intelligente della mente e rifiuta di accettare queste
idee con tutto il loro peso. Così l’uomo si è
salvato dalla disperazione ma è atterrato nella confusione.
Le sue convinzioni fondamentali sono confuse e incerte e di conseguenza
lo sono anche le sue azioni.
Se soltanto lasciasse cadere sul centro la luce della consapevolezza
e affrontasse la questione delle sue fondamentali convinzioni, potrebbe
creare ordine dove c’è disordine. Questo potrebbe “educarlo”
nel senso di condurlo fuori dal buio della sua confusione metafisica.
Non credo comunque che ciò si possa ottenere, senza che egli
accetti consapevolmente- anche se soltanto provvisoriamente- un
numero di idee metafisiche che sono quasi direttamente opposte alle
idee (sbocciate nel XIX secolo) che hanno alloggiato nella sua mente.
Farò tre esempi.
Mentre le idee del XIX secolo negano o cancellano la gerarchia dei
livelli nell’universo, la nozione di un ordine gerarchico
è un indispensabile strumento della comprensione. Senza il
riconoscimento dei ”livelli dell’Essere” e dei
“gradi di significato” non possiamo rendere intelleggibile
il mondo a noi stessi né avere la minima possibilità
di definire la nostra propria posizione, la posizione dell’uomo,
nello schema dell’universo.
E’ solo quando riusciamo a vedere il mondo come una scala,
e quando riusciamo a vedere la posizione dell’uomo nella scala,
che noi possiamo riconoscere un compito significativo della vita
dell’uomo sulla terra. Forse è un compito dell’uomo
– o semplicemente, se volete, la felicità dell’uomo-
il raggiungimento di un grado più alto di realizzazione delle
sue potenzialità, un livello più alto dell’essere
o del “grado di significato” di quello che gli è
dato ”naturalmente”: non possiamo nemmeno studiare questa
possibilità se non riconoscendo l’esistenza di una
struttura gerarchica. Fino a che interpreteremo il mondo attraverso
le grandi e vitali idee del XIX secolo, saremo ciechi a queste differenze
di livello, perchè siamo stati accecati.
Non appena accettiamo l’esistenza dei “livelli dell’essere”
possiamo subito capire, ad esempio, perchè i metodi della
fisica applicata non possono essere applicati allo studio della
politica o dell’economia, o perchè le scoperte della
fisica- come ha riconosciuto Einstein- non hanno alcuna implicazione
filosofica.Se noi accettiamo la divisione Aristotelica della filosofia
in ontologia ed epistemologia, l’affermazione dell’esistenza
dei i livelli dell’essere è una affermazione ontologica;
adesso ne aggiungo una epistemologica: la natura del nostro pensare
è tale che non possiamo fare a meno di pensare per opposti.
E’ abbastanza facile vedere che durante tutta la nostra vita
noi ci troviamo di fronte al compito di riconciliare gli opposti
che, nel pensiero logico, non possono essere riconciliati. I tipici
problemi della vita sono insolubili al livello dell’essere
nel quale normalmente ci troviamo. Come si possono riconciliare
le richieste di libertà e la disciplina nell’educazione?
Numerose madri e insegnanti lo fanno, infatti, ma nessuno sa descrivere
la soluzione. Lo fanno portando nella situazione una forza che appartiene
a un più alto livello dove gli opposti vengono trascesi-
il potere dell’amore.
G.N.M. Tyrell ha proposto i termini “divergente” e “convergente”
per distinguere i problemi che non possono essere risolti attraverso
il ragionamento logico da quelli che possono.
La vita è mantenuta in movimento dai problemi divergenti
che debbono essere “vissuti” e si risolvono solo con
la morte. I problemi convergenti, invece, sono la più utile
invenzione umana; non esistono, in quanto tali, nella realtà,
ma vengono creati da un processo di astrazione. Quando sono stati
risolti, la soluzione può essere scritta e passata ad altri
che possono applicarla senza bisogno di riprodurre lo sforzo necessario
per trovarla. Se questo fosse il caso delle relazioni umane nella
vita familiare, nell’economia, nella politica, nell’educazione
e così via, ebbene, non so come finire la frase.
Non ci sarebbero più relazioni umane ma soltanto reazioni
meccaniche; la vita sarebbe una morte vivente. I problemi divergenti,
costringono l’uomo a estendersi a un livello al di sopra di
sé; richiedono e provocano il contributo di forze da un livello
superiore portando così amore, bellezza, bontà e verità
nelle nostre vite. E’ solo con l’aiuto di queste forze
che gli opposti possono essere riconciliati nella situazione vivente.
Le scienze della fisica e la matematica hanno a che fare soprattutto
con problemi convergenti. E’ per questo che possono progredire
per accumulazione e ogni generazione può cominciare proprio
da dove i predecessori hanno lasciato. Il prezzo è comunque
alto. Trattare esclusivamente problemi convergenti non porta nella
vita, ma lontano da essa.
<Fino all’età di 30 anni,o
forse più -scrisse Charles Darwin nella sua autobiografia-
ogni genere di poesia....mi piaceva molto e perfino da scolaro sentivo
una gioia intensa nel leggere Shakespeare, specialmente le sue opere
storiche. Ho anche detto che in passato la pittura e la musica mi
davano un piacere grandissimo. Oggi e da molti anni, invece, non
sopporto di leggere nemmeno una strofa di poesia: ho provato recentemente
a leggere Shakespeare e l’ho trovato cosi insopportabilmente
noioso da farmi venire la nausea. Ho anche perso qualunque gusto
per la pittura e la musica....La mia mente sembra essere diventata
una macchina per setacciare le grandi leggi da una grande collezione
di fatti, ma perché questo abbia causato l’atrofia
solo di quella parte del cervello da cui dipendono le inclinazioni
più alte, non riesco a capirlo...
La perdita di quei talenti è una perdita della felicità
e può anche essere dannosa per l’intelletto e più
sicuramente per il carattere morale, poiché indebolisce la
parte emozionale della nostra natura.> Questo impoverimento,
descritto da Darwin in modo tanto commovente, finirà col
sopraffare tutta la nostra civiltà se permetteremo alle attuali
tendenze di continuare con quella che Gilson chiama “l’estensione
della scienza positiva ai fatti sociali”.
< Tutti i problemi divergenti possono diventare problemi convergenti
per un processo di “riduzione”.>
Il risultato, comunque è la perdita di tutte le qualità
più elevate che nobilitano la vita dell’uomo ottenendo
in cambio il degrado, non solo della parte emozionale della nostra
natura ma anche, come ha percepito Darwin, del nostro intelletto
e del carattere morale.
I segni oggi sono molto visibili. I veri problemi del vivere- nella
politica, nell’economia, nell’educazione, nel matrimonio,
etc.- sono sempre problemi di superamento o riconciliazione degli
opposti. Sono problemi divergenti e non trovano soluzione nel senso
comune della parola. Richiedono all’uomo non solo l’impiego
dei suoi poteri razionali ma l’impegno della sua intera personalità.
Naturalmente, vengono sempre proposte soluzioni spurie, attraverso
formule brillanti, ma queste non funzionano a lungo poiché,
invariabilmente trascurano uno dei due opposti perdendo in tal modo
proprio la qualità della vita umana. In economia, la soluzione
offerta può provvedere alla libertà ma non alla pianificazione,
o viceversa. Nell’organizzazione industriale può provvedere
alla disciplina ma non alla partecipazione dei lavoratori alla gestione
o viceversa. Nella politica, può provvedere alla leadership
senza democrazia, o, di nuovo, alla democrazia senza leadership.
Essere alla prese con i problemi divergenti tende a diventare estenuante,
preoccupante e noioso. Perciò la gente cerca di evitarli
e li sfugge. Un indaffarato dirigente che ha avuto a che fare con
problemi divergenti tutto il giorno, nel suo viaggio di ritorno
a casa, leggerà un romanzo giallo o risolverà un problema
di parole crociate. Perchè tutti e due presentano problemi
convergenti e questo è rilassante.
Richiedono un po’ di lavoro del cervello, anche difficile,
ma non richiedono di sforzarsi per tendere a un livello superiore
che è la sfida specifica posta da un problema divergente,
un problema in cui gli opposti non riconciliabili devono essere
riconciliati. Ma sono solo questi ultimi che costituiscono la sostanza
vera della vita.
Infine, arrivo alla terza classe di nozioni che appartengono veramente
alla metafisica, sebbene vengano sempre considerate separatamente,
cioè all’etica. Le più potenti idee del XIX
secolo, come abbiamo visto, hanno negato o almeno oscurato l’intero
concetto dei ”livelli dell’essere” e l’idea
che alcune cose siano più elevate di altre. Questo ha naturalmente
significato la distruzione dell’etica che è basata
sulla distinzione tra bene e male e afferma che il bene è
più elevato del male.
Ancora una volta, le colpe dei padri sono ricadute sulla terza e
la quarta generazione che adesso si trovano a crescere senza istruzioni
morali di alcun genere. Coloro che concepirono l’idea che
“ la moralità è un non senso” lo fecero
con una mente attrezzata di idee morali.
Ma le menti della terza e della quarta generazione non lo sono più:
sono piene di idee concepite nel XIX secolo, in particolare l’idea
che “la moralità è un non senso”, che
tutto quello che all’apparenza è più elevato,
non è davvero altro che qualcosa di basso e volgare.
La confusione che ne è derivata è indescrivibile.
Qual’è il Leitbild, come dicono i tedeschi, l’immagine-guida,
secondo cui i giovani potrebbero provare a formarsi ed educarsi?
Non c’è, o piuttosto, c’è un cumulo tale
e una confusione tale di immagini che non ne viene fuori alcuna
immagine-guida sensata. Gli intellettuali, la cui funzione sarebbe
quella di selezionare queste cose, passano il tempo a proclamare
che tutto è relativo- o qualcosa di simile. Oppure trattano
le questioni etiche nei termini del più disinvolto cinismo.
Far un esempio a cui ho già accennato prima. E’ significativo
perchè viene da uno degli uomini più influenti del
nostro tempo, Lord Keynes. <Per almeno
altri cento anni> scrisse <dobbiamo
fingere con noi stessi e con gli altri che il bello è osceno
e che l’osceno è bello; perchè l’osceno
è utile e il bello non lo è. Avarizia, usura e precauzione
debbono essere ancora per un po’ i nostri dei> Quando
uomini grandi e intelligenti parlano così, non possiamo sorprenderci
se nasce una certa confusione tra il bello e l’osceno che
porta al discorso incomprensibile- fin tanto che le cose sono tranquille-
e al crimine, quando cominciano a movimentarsi. Che avarizia, usura
e precauzione (sicurezza economica) dovrebbero essere i nostri déi
fu semplicemente una idea brillante per Keynes; sicuramente i suoi
dèi erano più nobili. Ma le idee sono le cose più
potenti della terra e non è un’ esagerazione dire che
al momento gli déi che egli raccomandò sono stati
messi sul trono. In etica e in tanti altri campi, abbiamo abbandonato
in modo azzardato e deliberatamente, la nostra grande eredità
classica-cristiana. Abbiamo perfino svalutato le parole stesse senza
le quali non si può portare avanti un discorso etico, parole
come virtù, amore, temperanza. Come risultato, siamo totalmente
ignoranti, totalmente ineducati in una materia che, di tutte le
materie concepibili, la più importante. Non abbiamo idee
con cui pensare e perciò siamo soltanto pronti a credere
che l’etica sia un campo in cui pensare non fa bene. Chi conosce
qualcosa oggi dei sette vizi capitali o delle quattro virtù
cardinali? Chi potrebbe anche solo nominarle? E se rispetto a queste
venerabili, vecchie idee, si pensa che non valga nemmeno la pena
considerarle, quali nuove idee hanno preso il loro posto? Che cosa
deve prendere il posto dello spirito e della metafisica che distrugge
la vita, ereditate dal XIX secolo? Il compito della nostra generazione,
non ho alcun dubbio, è una ricostruzione della metafisica.
Non è che dobbiamo inventare niente di nuovo; allo stesso
tempo non è sufficiente semplicemente ritornare alle vecchie
formulazioni. Il nostro compito e il compito di tutta l’educazione
è quello di capire il mondo presente, il mondo in cui viviamo
e facciamo le nostre scelte.
I problemi dell’educazione sono semplicemente i riflessi dei
problemi più profondi della nostra epoca. Non possono essere
risolti dall’organizzazione, dall’amministrazione o
dal consumo di denaro, anche se l’importanza di tutto ciò
non può essere negata.
Noi stiamo soffrendo di una malattia metafisica e la cura deve perciò
essere metafisica.
L’educazione che fallisce nel chiarire le nostre convinzioni
centrali è puro addestramento o indulgenza. Perchè
sono queste convinzioni ad essere in disordine e fino a che il carattere
antimetafisico del presente persiste, il disordine continuerà
ad aumentare. L’educazione, lungi dall’essere considerata
la risorsa umana più grande, diventerà allora un agente
di distruzione. (corruptio optimi pessima).
estratto da: E.F. Schumacher,
Small is beautiful: A Study of Economics As If People Mattered,
1973
|