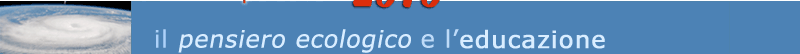|
|
QUALITATIVE GROWTH
di Fritjof Capra e Hazel Henderson, 2009
traduzione di Franca Bossalino
Una struttura concettuale per trovare soluzioni alla crisi attuale che siano economicamente sane, ecologicamente sostenibili e socialmente giuste.
La attuale recessione globale ha conquistato il primo posto nelle news fin dall’inizio dell’anno. Ogni giorno veniamo a sapere che la gente compra sempre meno automobili, che le fabbriche produttrici di attrezzature e veicoli sportivi chiudono, che il consumo di petrolio (e anche il costo) diminuisce drammaticamente, che i negozianti al dettaglio si lamentano perché i consumatori spendono sempre meno negli articoli di lusso e via dicendo.
Da un punto di vista ecologico, sono buone notizie, dal momento che la continua crescita del consumo di questo genere di materiali su un pianeta finito può portare soltanto a una catastrofe. Tuttavia, emerge un contraddittorio “paradosso dell’economia”. Per esempio, i 787 miliardi di dollari del piano di incentivi del Presidente Obama, è stato pensato per aumentare il livello dei consumi, sia nel settore pubblico che in quello privato e, allo stesso tempo, l’aumento dei risparmi è auspicabile per contenere il deficit. Contemporaneamente, giorno dopo giorno, veniamo a conoscenza di aziende che rispondono alla diminuzione delle loro vendite riducendo la forza lavoro, piuttosto che riducendo i loro profitti o andare in perdita. Pertanto, se ogni diminuzione del materiale consumato è - ecologicamente parlando- una buona notizia- implica, tuttavia, una sofferenza umana, perché l’occupazione diminuisce. Nel contempo, più di due miliardi di persone che non consumano vengono ulteriormente deprivati della crescita economica convenzionale, dal libero mercato e dalla globalizzazione. Sembra che la nostra sfida cruciale sia quella di passare da un sistema economico basato sulla nozione di crescita illimitata a un sistema economico sostenibile ecologicamente e socialmente giusto.
“Niente crescita” non è la risposta. La crescita è una caratteristica essenziale di tutta la vita; una società o un’economia che non crescono, prima o poi muoiono. Nella Natura, la crescita, comunque, non è lineare e illimitata. Mentre certe parti di un organismo, o di un ecosistema crescono, altre deperiscono rilasciando e riciclando i loro componenti che diventano risorse per una nuova crescita.
In questo saggio, vogliamo definire e descrivere questo genere di crescita equilibrato e sfaccettato, ben noto ai biologi e agli ecologi, i cui principi si applicano all’economia e, in particolare, all’attuale crisi economica. Proponiamo di usare il termine “crescita qualitativa” in contrapposizione al concetto di “crescita quantitativa” usato dagli economisti.
L’abitudine degli economisti ad equiparare la crescita con il “progresso” è stata criticata dagli ambientalisti, dagli ecologi, e dai gruppi di cittadini che si battono per la giustizia sociale. Al secondo Summit delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro nel 1992, più di170 governi sono stati d’accordo sulla necessità di correggere la visione della crescita “quantitativa”, lanciando una sfida agli economisti. Questa sfida è stata ignorata fino a tempi recenti, poiché richiedeva che le compagnie e le agenzie governative includessero nel loro bilancio i costi sociali e ambientali che solitamente vengono “esternalizzati”. Le preoccupazioni sul cambiamento climatico globale si stanno concentrando sulla “internalizzazione” di tali costi.
Il PIL (prodotto interno lordo)
La maggior parte degli economisti ancora misura la ricchezza di un paese in termini di PIL in cui tutte le attività economiche associate ai valori monetari vengono sommate indiscriminatamente, mentre tutti gli aspetti non-monetari dell’economia vengono ignorati. I costi sociali, come quelli degli incidenti, delle guerre, dei litigi e della salute vengo sommati come contributi positivi al PIL e la crescita indifferenziata di questo grezzo indice quantitativo viene considerato il segno di una economia ”in buona salute”. L’idea che la crescita possa essere un impedimento, possa essere malata o patologica viene raramente preso in considerazione dagli economisti, nonostante siano stati criticati per decenni.
L’obiettivo della maggioranza delle economie nazionali è di raggiungere una crescita illimitata del PIL attraverso la continua accumulazione di beni materiali e l’espansione dei servizi. La super-espansione dei servizi finanziari, in particolare, è un parassita dell’economia reale e ha portato all’attuale collasso. Poiché i bisogni umani sono limitati, mentre l’avidità umana non lo è, la crescita economica può essere mantenuta attraverso la creazione artificiale dei bisogni, per mezzo della pubblicità. I beni prodotti e venduti in questo modo, sono spesso non-necessari e, perciò, sono essenzialmente spreco. Per di più, l’inquinamento e il depauperamento delle risorse naturali generati da questo spreco enorme di beni non-necessari è esacerbato dallo spreco di energia e di materiali in processi di produzione inefficienti. Il riconoscimento dell’errore del concetto tradizionale della crescita economica, che fu messo in evidenza da uno di noi già nel 1971, è il primo passo per il superamento della crisi economica. L’attivista del cambiamento sociale Frances Moore Lappè aggiunge: <Dal momento che quello che chiamiamo “crescita” è per lo più spreco, chiamiamola così! Chiamiamola economia dello spreco e della distruzione. Definiamo la crescita come quella che migliora la vita- come generazione e ri-generazione- e dichiariamo che è quello di cui il pianeta ha più bisogno.> Questa nozione di “crescita che migliora la vita” è quello che intendiamo per crescita qualitativa- una crescita che migliora la qualità della vita. Negli organismi viventi, negli ecosistemi e nelle società, la crescita qualitativa consiste nell’aumento della complessità, della raffinatezza e della maturità. Al fine di arrivare a una piena comprensione dei concetti di crescita quantitativa e crescita qualitativa, sarà utile ricordare i ruoli che le quantità e le qualità hanno avuto nella storia della scienza occidentale.
Quantità e qualità nella scienza occidentale
All’alba della scienza moderna, nel Rinascimento, Leonardo da Vinci dichiarò che il pittore, “con speculazione filosofica e sottile considera tutte le qualità della forma”. Sostenne che l’arte o l’abilità nel dipingere deve essere sostenuta dalla scienza del pittore cioè dalla conoscenza delle forme viventi, per mezzo della sua comprensione intellettuale della loro intrinseca natura e dei suoi principi fondamentali.
La scienza di Leonardo, come quella di Galileo cento anni dopo, era basata sull’osservazione sistematica della natura, sul ragionamento e la matematica- l’approccio oggi conosciuto come metodo scientifico- ma i suoi contenuti erano del tutto differenti dalla scienza meccanicistica sviluppata da Galileo, Cartesio e Newton. Era una scienza delle forme organiche, di qualità, di modelli di organizzazione e di processi di trasformazione.
Nel XVII secolo, Galileo postulò che, per essere efficaci nel descrivere la natura matematicamente, gli scienziati dovevano limitarsi allo studio di quelle proprietà dei corpi materiali- forme, dimensioni e movimento che potevano essere misurate e quantificate. Le altre proprietà, come il colore, il suono, il gusto o l’odore, erano puramente proiezioni soggettive che dovevano essere escluse dal dominio della scienza. La strategia di Galileo di dirigere l’attenzione dello scienziato verso le proprietà quantificabili della materia ha avuto molto successo nella fisica classica, ma a un prezzo molto alto.
Durante i secoli che seguirono, l’attenzione alle quantità venne estesa dallo studio della materia a tutti i fenomeni naturali e sociali, all’interno della struttura meccanicistica della visione del mondo della scienza di Cartesio e di Newton.
Escludendo il colore, il suono, il gusto, il tatto e l’odorato- non considerando le qualità più complesse come la bellezza, la salute o la sensibilità etica- l’enfasi sulla quantificazione ha impedito agli scienziati, per alcuni secoli di comprendere molte proprietà essenziali della vita. Nel XX secolo, l’approccio limitato meccanicistico e quantitativo ha interferito notevolmente nello sviluppo della biologia, della psicologia e delle scienze sociali.
Gli ultimi tre decenni, comunque, hanno visto rinnovarsi l’attenzione alla qualità. Durante questi decenni, è emersa nella scienza una nuova concezione sistemica della vita che presenta molte similitudini sorprendenti con la visione di Leonardo di 500 anni fa.
Oggi, l’universo non è più considerato una macchina composta da parti indipendenti. Abbiamo scoperto che il mondo materiale, in ultima analisi, è una rete di modelli inseparabili di relazioni; che il pianeta nella sua totalità è un sistema vivente che si auto-regola.
La visione del corpo umano come macchina, e della mente come entità separate, viene sostituito da una visione che vede non solo il cervello, ma anche il sistema immunitario, i tessuti corporei e perfino la singola cellula come un sistema vivente cognitivo.
L’evoluzione non è più considerata una lotta per l’esistenza, ma una danza collettiva in cui la creatività e la continua emergenza di innovazione sono le forze trainanti. E con la nuova enfasi sulla complessità, sulle reti e sui modelli di organizzazione, una nuova scienza della qualità sta lentamente emergendo.
La natura della qualità
La nuova concezione sistemica della vita rende possibile formulare una definizione scientifica di qualità. Infatti, sembra che ci siano due significati differenti del termine- uno oggettivo e l’altro, soggettivo. In senso oggettivo, le qualità di un sistema complesso si riferiscono alle proprietà del sistema che nessuna delle sue parti esibisce.
Le quantità, come la massa o l’energia, descrivono le proprietà delle parti e ci dicono che la loro somma totale è uguale alla corrispondente proprietà dell’insieme, per esempio, della massa totale o dell’energia.
Le qualità, come lo stress o la salute, al contrario, non possono essere espresse come la somma delle proprietà delle parti. Le qualità nascono dai processi e dai modelli di relazione tra le parti. Di conseguenza, non possiamo conoscere la natura dei sistemi complessi, come gli organismi, gli ecosistemi, le società e le economie, se cerchiamo di descriverle in termini puramente quantitativi. Le quantità possono essere misurate, le qualità debbono essere graficizzate.
Allo spostarsi dell’attenzione dalle quantità alle qualità, nelle scienze della vita, ha corrisposto uno spostamento concettuale nella matematica. E’ cominciato nella fisica negli anni ’60 con una particolare enfasi sulla simmetria- che è una qualità- e che si è intensificata nei decenni seguenti con lo sviluppo della teoria della complessità, o dinamica non-lineare, che è una matematica di modelli e di relazioni. Gli strani attrattori della teoria del caos e i frattali della geometria dei frattali sono modelli visuali che rappresentano le qualità dei sistemi complessi.
Nella sfera umana, la nozione di qualità sembra sempre includere riferimenti alle esperienze umane, che sono aspetti soggettivi. Per esempio, la qualità della salute di una persona può essere attestata in termini di fattori oggettivi, ma include un’ esperienza soggettiva del benessere come elemento significativo. Similmente, la qualità di una relazione umana deriva in larga misura dalle mutue esperienze soggettive. La qualità estetica di un’opera d’arte, come si dice, sta nell’occhio dell’osservatore.
Poiché tutte le qualità hanno origine dai processi e dai modelli di relazione, quando questi processi e queste relazioni coinvolgono gli esseri umani, includono necessariamente gli elementi soggettivi.
Di conseguenza, molti dei nuovi indicatori del progresso di un paese, usano approcci sistemici multi-disciplinari con appropriate metriche per misurare i molti aspetti della qualità della vita. Per esempio, gli Indicatori della Qualità della Vita (Calvert- Henderson), misurano dodici di questi aspetti usando i coefficienti monetari solo quando sono appropriati, mentre rifiutano lo strumento convenzionale della macro-economia, che aggrega in un unico numero, il PIL, tutti gli aspetti che sono qualitativamente differenti.
Crescita e Sviluppo
Le precedenti considerazioni sulle qualità e le quantità si possono applicare al concetto di crescita qualitativa e al fenomeno dello sviluppo, che è relativo alla crescita. Come il termine “crescita” anche il termine “sviluppo” viene usato oggi in due sensi molto differenti- uno qualitativo e l’altro quantitativo.
Per i biologi, lo sviluppo è una proprietà fondamentale della vita. Secondo la nuova conoscenza sistemica della vita, ogni sistema vivente incontra occasionalmente punti di instabilità in cui si verifica una rottura o più frequentemente l’emergenza spontanea di nuove forme di ordine. L’emergenza spontanea della novità è uno dei marchi di fabbrica della vita. E’ stata riconosciuta come l’origine dinamica dello sviluppo, dell’apprendimento, dell’evoluzione. In altre parole, la creatività- la generazione di nuove forme- è una proprietà essenziale di tutti i sistemi viventi. Ciò significa che tutti i sistemi viventi si sviluppano; che la vita si estende continuamente per creare novità. Il concetto biologico di sviluppo implica un senso del complesso ‘dischiudersi’ degli organismi viventi, degli ecosistemi o delle comunità umane che stanno raggiungendo il loro potenziale.
Gli economisti, al contrario, limitano l’uso del termine ‘sviluppo’ a un‘unica dimensione economica, generalmente misurata in termini di PIL pro capite. L’immensa diversità dell’esistenza umana è stata compressa dentro questo concetto lineare, quantitativo e poi convertita in coefficienti monetari. Perciò, il mondo intero è stato arbitrariamente categorizzato in paesi “sviluppati”, paesi “in via di sviluppo” e paesi “sottosviluppati”. Gli economisti hanno riconosciuto soltanto il denaro e i flussi di contante, ignorando tutte le altre forme di ricchezza fondamentale- tutti i beni ecologici, sociali e culturali. Sembra chiaro che questa visione lineare dello sviluppo economico, adottata da economisti e politici, corrisponda a un concetto quantitativo della crescita economica, mentre il senso dello sviluppo biologico ed ecologico corrisponde alla nozione di crescita qualitativa. Un organismo o un’ ecosistema cresce secondo i propri stadi di sviluppo. Tipicamente, un organismo giovane attraverso periodi di rapida crescita fisica. Negli ecosistemi questa fase di rapida crescita è conosciuta come ‘sistema pioniere’, caratterizzato da una veloce espansione e colonizzazione del territorio. Questa è sempre seguita da una crescita più lenta, dalla maturazione e, alla fine, dal declino e decadenza oppure, negli ecosistemi, dalla cosiddetta successione. Mentre i sistemi viventi maturano, i loro processi di crescita passano dalla crescita quantitativa a quella qualitativa.
Quando studiamo la natura, possiamo vedere abbastanza chiaramente che la crescita quantitativa illimitata, promossa con tanto vigore dagli economisti e dai politici, è insostenibile. Un esempio istruttivo è la crescita rapida delle cellule cancerose che non riconosce confini e non è sostenibile perché le cellule cancerose muoiono quando muore l’organismo ospitante.
Similmente, la crescita economica quantitativa illimitata su un pianeta finito non può essere sostenibile. Al contrario, la crescita economica qualitativa può essere sostenibile se comprende un equilibrio dinamico tra crescita, declino e riciclo e se include anche lo sviluppo in termini di apprendimento e maturazione.
La distinzione tra crescita economica quantitativa e qualitativa illumina il concetto ampiamente usato ma problematico di “sviluppo sostenibile”. Se il termine “sviluppo” viene usato nel senso economico ristretto associato alla nozione di crescita quantitativa illimitata, un tale sviluppo economico non può mai essere sostenibile e il termine “sviluppo sostenibile” sarebbe un ossimoro. Se il processo dello sviluppo viene compreso come più che un processo puramente economico, includendo le dimensioni sociali ecologiche e spirituali e se è associato alla crescita economica qualitativa, allora, un tale processo sistemico multi- dimensionale può veramente essere sostenibile. Nelle aziende, nelle amministrazioni e nella società civile, oggi molti usano il termine ‘sostenibilità’ per analizzare questi temi. Esistono anche centinaia tra corsi e nuovi programmi, e anche società di consulenza. Resta, tuttavia, ancora molto lavoro da fare per definire la ‘sostenibilità’ in tutti questi contesti.
La Crescita Economica Qualitativa e la crisi globale
Ritorniamo adesso alla sfida cruciale della nostra crisi economica ed ecologica: come possiamo trasformare l’economia globale da un sistema che lotta per una crescita quantitativa illimitata, che è indubbiamente insostenibile, a un altro che sia ecologicamente sensato, senza generare stenti per l’umanità attraverso più occupazione?
Il concetto di crescita economica qualitative sarà uno strumento fondamentale in questa impresa. Invece di valutare lo stato dell’economia in termini di grezza misura del PIL, dobbiamo distinguere tra crescita “buona” e crescita “cattiva” e poi potenziare la prima a spese della seconda, in modo tale che le risorse naturali e umane legate a processi di produzione insensati e dispendiosi possano essere liberate e riciclate per essere usate nei processi efficienti e sostenibili.
Un passo avanti in questa direzione è stata la Conferenza “Oltre il PIL” svoltasi al Parlamento Europeo a novembre 2007 su iniziativa della Commissione Europea insieme al WWF per la natura, l’OECD, l’EUROSTAT (Europe’s Statistical Agency) e il Club di Roma.
Dal punto di vista ecologico, la distinzione tra crescita “buona” e “cattiva” è ovvia.
La crescita “cattiva” è quella dei processi produttivi e dei servizi che si basano sui combustibili fossili, che emettono sostanze tossiche, impoveriscono le nostre risorse naturali e degradano gli ecosistemi della Terra.
La crescita “buona” è quella dei processi di produzione e dei servizi più efficienti che comportano energie rinnovabili, zero emissioni, il riciclo continuo delle risorse naturali e il restauro degli ecosistemi della Terra. Il cambiamento climatico e le altre manifestazioni della crisi ambientale globale impongono di passare dai processi di produzione distruttivi alle alternative “verdi” o al “progetto ecologico”; la conseguenza sarà che queste alternative risolveranno anche la crisi economica in modo socialmente giusto.
Politiche sistemiche corrispondenti si trovano nella Iniziativa per l’Economia Verde dell’ONU lanciata a dicembre 2008 a Ginevra dal UN Environmental Programme, dall’International Labor Organization, and the UN Development Program che è stata un’idea di uno di noi. Altre iniziative simili sono il Green New Deal in Inghilterra e il Global Marshall Plan per una Economia Verde socialmente giusta, in Germania. Negli ultimi anni, c’è stata una crescita straordinaria di pratiche e di progetti che adesso sono ben documentati. Questi comprendono:
-
una rinascita generale delle culture organiche;
-
l’organizzazione di differenti industrie in gruppi ecologici in cui i rifiuti di una qualunque delle industrie è una risorsa per l’altra;
-
lo spostamento da una economia orientata al prodotto a un’economia di “servizi e flussi”, in cui materiali grezzi e componenti industriali circolano continuamente tra produttori e fruitori;
-
edifici progettati per produrre più energia di quanta ne consumino, che non producono rifiuti e monitorizzano la propria prestazione; automobili elettriche ibride che raggiungono un’efficienza di oltre 50mpg e un notevole aumento di energia eolica oltre le proiezioni più ottimistiche. Infatti con lo sviluppo degli ibridi a ricarica e delle fattorie del vento, le automobili del futuro useranno principalmente l’energia eolica
Tutte queste tecnologie del progetto ecologico e tutti i progetti incorporano i principi fondamentali dell’ecologia e perciò hanno in comune delle caratteristiche fondamentali:
-
tendono ad essere progetti a piccola scala con abbondanza di diversità;
-
sono efficienti dal punto di vista energetico, non inquinanti e finalizzati alla comunità;
-
e soprattutto tendono all’uso intensivo di mano d’opera attraverso l’investimento nelle tecnologie verdi, creando un gran numero di posti di lavoro.
Infatti, il potenziale di occupazione locale che può crearsi investendo nelle tecnologie verdi, nel restauro degli ecosistemi e nella ri-progettazione delle nostre infrastrutture è enorme- come è stato riconosciuto dal trasformare queste idee in realtà con l’American Recovery and Reinvestment Act del 2009.
Una roadmap dettagliata per passare da una crescita quantitativa a una qualitativa e poi trovare soluzioni alla crisi globale che siano ecologicamente sostenibili e socialmente giuste, va oltre lo scopo di questo saggio. Alcuni passi che sembrano critici, sono i seguenti:
-
I modelli di crescita qualitativa debbono essere formulati da gruppi multi-disciplinari, che si confrontino nel mondo dell’economia, nel governo e nei media. Di conseguenza, i nuovi insiemi più ampi di indicatori socio/ambientali debbono essere adottati adesso. Questo richiederà la volontà politica, la pressione pubblica e l’educazione degli editori dei media e dei giornalisti.
-
Il sistema fiscale deve essere ristrutturato, riducendo le tasse sul lavoro e aumentandole sulle varie attività che distruggono l’ambiente, così da “internalizzarle” e incorporarne i costi nei prezzi di mercato. Queste tasse “verdi” sono state adottate in molti paesi. Dovrebbero comprendere la tassa sul carbone e la tassa sulla benzina, che possono essere aggiustate gradualmente mentre vengono compensate con riduzioni delle tasse relative al reddito e agli stipendi. Spostare le tasse dal reddito e dagli stipendi agli sprechi, a tutto l’inquinamento al carbone e alle risorse non rinnovabili, gradualmente spingerà fuori dal mercato le tecnologie insensate e dannose e i corrispondenti modelli di consumo. Questo aumenterà il valore delle azioni investite nelle industrie produttrici di alternative verdi.
-
Oltre allo spostamento delle tasse, le industrie e le aziende debbono riesaminare i loro processi di produzione per determinare quali siano quelli ecologicamente distruttivi che perciò debbono essere modificati. Allo stesso tempo dovrebbero diversificarsi nella direzione dei prodotti e di servizi verdi. Poiché sono stati adottati nuovi protocolli per la contabilità che tengono conto dei fattori sociali, ambientali e di governance (ESG), le aziende, grazie ai loro investitori, si stanno orientando verso prodotti, servizi e pratiche più sostenibili, comprese quelle relative all’l’istituzione di fondi per i mutui socialmente responsabili, ai sindacati, ai gruppi civici e agli investitori privati. […]
-
Tutte queste riforme coinvolgeranno cambiamenti di percezione, come la smaterializzazione delle nostre economie produttive (dal prodotto al servizio). Per esempio, un’industria automobilistica dovrebbe rendersi conto che il suo business non è necessariamente vendere le macchine, ma piuttosto provvedere alla mobilità che si può anche ottenere, tra l’altro, nel produrre più autobus e treni e riprogettando le nostre città. Così gli stati e specialmente gli Stati Uniti dovrebbero rendersi conto che combattere il cambiamento climatico è il più importante e urgente argomento della sicurezza. L’Amministrazione Obama dovrebbe ridurre di conseguenza il budget del Pentagono e incrementare i fondi per la diplomazia e la costruzione di una nuova economia “verde”.
-
A livello individuale, un corrispondente cambiamento di percezione si sposterà dalla ricerca della soddisfazione nel consumo materiale alla ricerca della medesima nelle relazioni umane e nella costruzione della comunità. Tali cambiamenti di valore vengono oggi promossi da molti gruppi civici come anche da molte serie televisive come “ Ethical Markets”. Una proposta per tagliare i crediti d’imposta alle società che fanno pubblicità all’estero, ha come obiettivo la riduzione della pubblicità in modo discreto senza mettere in pericolo i diritti di libertà di parola.
La crescita qualitativa oltre l’economia
La sfida del cambiamento da una crescita economica quantitativa ad una qualitativa, creerà nuove industrie mentre ridurrà la dimensione di altre secondo criteri ecologici e sociali. Con l’applicazione dei prezzi pieni, i costi del ciclo di vita, insieme a quelli sociali e ambientali e all’auditing etico, che stanno diventando la norma, si può vedere quali processi produttivi dovrebbero essere potenziati e quali, dovrebbero essere gradualmente eliminati. Qualunque impegno serio in questo ambito, renderà evidente che i maggiori problemi del nostro tempo- l’energia, l’ambiente, il cambiamento climatico, la sicurezza del cibo e la sicurezza finanziaria- non possono essere compresi separatamente. Sono problemi sistemici, il che significa che sono tutti interconnessi e interdipendenti.
Per ricordare alcune di queste interdipendenze, la pressione demografica e la povertà formano un circolo vizioso che, esacerbato dalle tecnologie ad uso intensivo di capitale, porta all’impoverimento delle risorse- meno posti di lavoro, livelli del mare in aumento, riduzione delle foreste, collasso della pesca, erosione dei suoli, povertà sempre maggiore e via dicendo. La difettosa economia basata sulla crescita del PIL, peggiora il cambiamento climatico e aggrava sia l’impoverimento delle risorse che la povertà, portando perfino al fallimento degli stati i cui governi non possono più dare sicurezza ai propri cittadini, alcuni dei quali, nella disperazione, diventano terroristi.
La fondamentale interconnessione dei nostri maggiori problemi mette in chiaro che abbiamo bisogno di andare oltre l’economia per superare la crisi economica. D’altra parte,la scienza sistemica rende possibile trovare soluzioni sistemiche- soluzioni che risolvono alcuni problemi in una sola volta.
Per esempio, il cambiamento da una agricoltura chimica, industriale, alla grande scala ad una agricoltura organica, finalizzata alla comunità, contribuirebbe in modo significativo alla soluzione di tre dei nostri problemi più grandi: la dipendenza energetica, il cambiamento climatico e la crisi dell’assistenza medica.
Numerose soluzioni sistemiche di questo genere sono state sviluppate recentemente e sperimentate in tutto il mondo. E sono la prova del fatto che il cambiamento dalla crescita quantitativa a quella qualitativa, usando tutti gli indicatori della qualità della vita e del benessere, può guidare le nazioni nel passaggio dalla distruzione ambientale alla sostenibilità ecologica, dalla disoccupazione, povertà e spreco alla creazione di un lavoro significante e dignitoso. Questa transizione globale alla sostenibilità non è più un problema concettuale né tecnico. E’ un problema di valori e di volontà politica.
testo originale
|